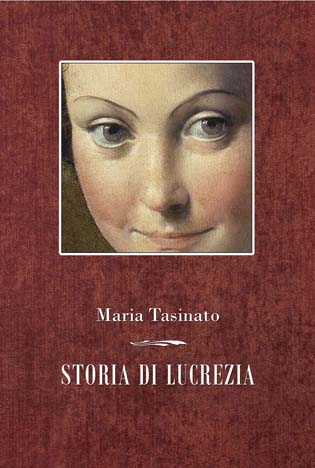“Diamoci del tu”: l’antenato del “lettore” nei poemi omerici… e non solo
Da troppo tempo mi devo decidere a scrivere almeno qualcosina a proposito di un problema estetico che mi ossessiona fin dall’adolescenza. Si tratta dell’insorgere della seconda persona singolare in certi appelli che l’autore, o chi per lui, fa ad un personaggio… tutto da scoprire.
M’accorgo d’esser stata parecchio sibillina e, come se non bastasse, di aver scelto un titolo maledettamente fuorviante. Perché qui non è affatto in gioco il “darsi del tu”, propriamente detto, tanto più che gli Antichi non conoscevano formule di cortesia e non si davano del “voi” o del “lei”, ma sempre e solo del tu, anche tra schiavo e padrone, tra giovani e vecchi eccetera.
(Tra parentesi, sarebbe interessante studiare per bene come e quando nacquero quei modi riguardosi di rivolgersi agli altri, modi che, ci piacciano o no, noi tutti conosciamo e che oramai fan parte delle cosiddette “buone maniere”).
Sicché, per chiarirvi subito dove voglia andare a parare, vi cito quei versi che fecero, tanto tempo fa, da miccia a questo mio imperituro assillo. Si tratta de Il canto d’amore di J. Alfred Prufrock, che T.S. Eliot (1988-1965) compose nel 1910-11, dunque, ancora ventitreenne.
Sentite che attacco potente:
Allora andiamo, tu ed io,
Quando la sera si stende contro il cielo
Come un paziente eterizzato disteso su una tavola;
Andiamo, per certe strade semideserte,
Mormoranti ricoveri
Di notti senza riposo in alberghi di passo a poco prezzo.
E ristoranti pieni di segatura e gusci d’ostriche;
Strade che si succedono come un tedioso argomento
Con l’insidioso proposito
Di condurti a domande che opprimono…
Oh, non chiedere “Cosa?”
Andiamo a fare la nostra visita.
Ma chi sono quei “you and I”? Forse chi alza in prima persona il suo scorato lamento (“divento vecchio… divento vecchio \ Porterò i pantaloni arrotolati in fondo”) si sta rivolgendo all’amata?
Il titolo sembrerebbe andare in tale direzione perché suona: The Love Song. Né mancano fugaci immagini che alludono ad un’intimità velatamente erotica: “la sera (…) gioca a fare la malata, \ sdraiata sul pavimento, qui fra te e me” o, peggio: “dopo le gonne strascicate sul pavimento”.
Eppure le cose, come sempre, non sono così semplici come sembrano. Perché quel “tu” sconfina pericolosamente con chi parla e sovente, ben più d’una volta, vi si congiunge in un “noi”: “Andiamo a fare la nostra visita”, nonché nella tremenda chiusa della poesia: “Finché le voci umane ci svegliano, e anneghiamo”.
Come uscirne?
Mi venne in soccorso il caro Baudelaire (1821-1867), in particolare, la prima poesia de Les fleurs du mal, che funge da premessa all’intera raccolta e che ha come titolo: Au lecteur.
Orbene, Baudelaire sta parlando dell’ennui, del tedio, della noia, insomma, e così conclude: “Tu lo conosci, lettore, questo mostro delicato \ –Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère!”
E perciò quel tu altri non è che il lettore, al quale chi scrive si sente legato da una fratellanza che sconfina nello sberleffo, ma insieme nella complicità.
Vi è, allora, in quel verso anche un’aria di provocazione, del tipo: “leggimi tu che pensi e pretendi di assomigliarmi e di capirmi!”.
Ed ora vi do un altro esempio di un aperto tono di sfida al lettore, traendolo da uno scrittore siculo, che oggi troppo pochi ricordano, il quale, tra l’altro, fu raffinato traduttore di Baudelaire: Gesualdo Bufalino (1920-1996).
Alludo, in particolare, al più riuscito – almeno a mio avviso – dei suoi romanzi: Le menzogne della notte (1988). Si tratta di una storia molto intricata in cui ognuno dei personaggi, tutti condannati a morte, nell’ultima notte prima dell’esecuzione, mistifica la propria identità e i propri trascorsi, intessendo racconti che si rivelano poi più o meno mendaci. Il tutto pur di non far scoprire chi sia l’ignoto capo d’una congiura politica, presumibilmente anti-borbonica.
Sorvolo sul linguaggio preziosamente barocco del romanzo, che già di per sé vale un Perù.
Ebbene, come dedica a Le menzogne, Bufalino mette solo tre micidiali parolette: “A noi due”!
Ed è chiaro che si tratta di una sfida bella e buona al lettore, affinché lui tenti di scoprire il gioco dei vari personaggi… o forse perché concluda che non vi può essere nessuna verità certa.
La questione dell’appello al “lettore” – o a chi per lui – mi si ripresentò recentemente allorché passai molto tempo in simbiosi con Eraclito e scrissi con il sangue Un anno con Eraclito, testo che potrete trovare sempre in questo sito, e a cui rimando.
In particolare, il tu tornò a galla quando mi trovai ad analizzare un frammento che lancia a tutti noi un messaggio tutt’altro che rassicurante:
I confini della psykhé, mentre vai, tu non li potrai trovare, anche se percorressi tutte le strade (hodoí): così esteso (bathýs) è il lógos che essa possiede (Diels-Kranz, 45, trad. it. mia).
D’accordo, ai tempi arcaici di Eraclito si viveva in un mondo ancora circonfuso di oralità, sicché non avrebbe alcun senso parlare di “lettore”, così come lo si conoscerà ben più tardi ma tutt’al più si può parlare di “ascoltatore”, visto che la lettura avveniva sempre a voce alta. Ossia abbiamo a che fare con qualcuno che può esser venuto a conoscenza delle taglienti sentenze dell’Oscuro o per averle udite per bocca di Eraclito stesso o trasmesse da qualcun altro.
Siccome ho già diffusamente scritto sul rapporto, tutt’altro che pacifico, che l’Oscuro ebbe, e per sempre avrà, con i suoi malcapitati e bistrattati “allievi”, e con “gli altri” in genere, rimando nuovamente a Un anno con Eraclito.
Vi basti, per il momento, sapere che Eraclito è il filosofo che per primo osò dire “io”, cosa che fu, all’epoca, un’autentica rivoluzione e che noi, ammalati come siamo di egolatria e di narcisismo, stentiamo a prendere nella dovuta considerazione.
Ed Eraclito, come s’è appena visto, ricorre anche a quel formidabile tu che campeggia enigmatico nel frammento 45.
Ma dove pesca Eraclito per mettere in scena questo raffinato gioco nell’uso delle persone verbali, specie singolari?
Eraclito non può ignorare i poeti lirici della Ionia, che, oltre ad esser della sua stessa zona geografica, gli sono di poco anteriori.
Ne cito solo due: i miei preferiti. Pensiamo a Saffo che dice orgogliosamente egó, proclamando le sue personalissime preferenze, andando contro i valori tradizionali:
Dicono che sopra la terra nera
La cosa più bella sia una fila di cavalieri,
o di fanti, o di navi
io invece: quello che si ama
(…)
Così ora mi torna in mente
Anattoria che ora è assente
Oh, preferirei rivedere,
il suo incedere amabile,
il candore splendente del viso,
piuttosto che i carri dei Lidi
e battaglie di uomini in armi!
Pensiamo a Mimnermo che proclama che, per lui, la vita in sé non vale nulla se privata dei piaceri tipici della giovinezza:
Che è mai la vita, che è mai la gioia senza Afrodite d’oro?
Ch’io possa morire, quando non mi curerò più
di un amore nascosto, dei dolci doni e del letto!
Tuttavia, in questi poeti troviamo spesso l’io ma non quel particolare tu che cerchiamo.
Per scovarlo dobbiamo andare ancora più indietro: dobbiamo tornare alla poesia epica. Per capirci, l’anonimo cantore dei poemi, assai raramente dice “io” ma più di una volta si rivolge con il tu a certi personaggi in particolare. E quali?
Ma facciamo una piccola pausa, giacché bisogna che, come sempre, paghi i miei sacrosanti debiti di gratitudine. Per quel che riguarda Eraclito, ho reso omaggio a Clémence Ramnoux e, per i poemi omerici, debbo ora fare un profondo inchino ad un’altra grande studiosa del mondo greco: Françoise Frontisi-Ducroux (d’ora in poi FFD).
Ebbene, senza La cithare d’Achille, avrei potuto continuare a leggere e rileggere l’Iliade e l’Odissea senza gran costrutto e, soprattutto, senza por la dovuta attenzione alle riflessioni estetiche che innervano i due poemi, ogniqualvolta è in gioco la funzione del canto.
E quale sarebbe mai tale funzione?
Sempre secondo FFD (p. 77), e io sono del suo medesimo parere, i due poemi ci fanno capire entrambi che la poesia offre ai mortali l’unico rimedio possibile: l’oblio dei mali e delle angosce che ci affliggono grazie alla dolcezza del canto che ci trasporta altrove, in un tempo che non è il nostro tempo.
Ma non basta: senza l’insostituibile soccorso di FFD, non avrei mai compreso appieno che i poemi omerici restano intramontabili non solo per l’incommensurabile bellezza dei loro versi, per le sfolgoranti immagini di cui pullulano, ma anche per essere poesia che riflette sulla poesia.
Ossia “metapoesia” (FFD, p. 47).
Lo so, è un termine antipatico e maledettamente sussiegoso, ma quando ci vuole, ci vuole!
Il fatto è che, molto prima di leggere FFD, avevo già dei conti in sospeso con Giambattista Vico (1668-1744), perché proprio non mi andava giù che l’Iliade e l’Odissea fossero considerati qualcosa di scaturito sorgivamente dalla “corpolentissima fantasia” di uomini, ancora “barbari” e incapaci di riflettere.
Ma che cosa sta a significare, innanzitutto, una poesia irriflessa? Senza volerci perdere nei verbosi meandri de La Scienza Nuova, una cosa vi posso assicurare: si tratta di una poesia che non pensa certo a come fare poesia.
Perciò ringrazio FFD per avermi regalato argomenti decisivi atti a rintuzzare le ubbíe spontaneiste di Vico e di tutti coloro – e non son pochi – che in seguito vi si ispireranno…
A questo punto, restava un problema: bisognava che mi decidessi ad affrontare più da vicino tutti e due i poemi e non solo l’Odissea. E mi fu di gran consolazione che anche FFD avesse scritto La cithare perché pentita d’aver trascurato l’Iliade.
Ve la devo dire tutta: l’Iliade, essendo io di carattere pacifista e anti-sanguinario, mi repelleva alquanto, date le troppe scene di bassa macelleria, che costellano le numerose battaglie e i troppi truculenti duelli.
Tuttavia, mi bastò leggere le primissime pagine de La cithare per immergermi, invece, in un’atmosfera che nulla ha a che vedere con la guerra. Si tratta dell’analisi di una bellissima, quanto sorprendente, piccola scena racchiusa nel libro nono dell’Iliade (vv. 185-191).
Se volessi banalizzare, direi che si tratta di una scena di relax, ma siccome questo è un termine maledettamente svilito oltre che riduttivo, preferisco dirlo in latino: una scena di squisito otium.
Per la cronaca, l’Atride (ossia Agamennone) si è oramai pentito d’aver fatto tremendamente adirare Achille, cosa che ha avuto come effetto funesto che l’eroe pievelóce si è ritirato dal campo di battaglia e, di conseguenza, i Troiani sono in rimonta e gli Achei ridotti a mal partito.
Ebbene, Nestore, re di Pilo, che è il vecchio saggio per eccellenza e che si assume il ruolo di paciere, porta con sé, tra gli altri, anche Ulisse.
Questi illustri messaggeri trovano il sommo guerriero Achille nei pressi della sua tenda, ma non mentre si esercita con le armi o in qualsiasi altro atteggiamento marziale, bensì mentre trae diletto da un’ornata cetra sonora. Ossia Achille, facendo vibrare le corde di tale strumento, suona e insieme canta le glorie degli eroi (vv. 186-189).
In questa scena, nota acutamente FFD (p. 19), vi è una sorta di mise en abyme dell’intera Iliade, in quanto Achille diviene una sorta di doppio del cantore omerico.
Alla performance di aedo di Achille, assiste rapito l’amato amico Patroclo (vv. 190-191). Patroclo, che ascolta “in silenzio” Achille, fattosi cantore, diventa, così, un: “auditeur exemplaire, miroir du publique” (FFD, p. 24).
Nell’Odissea abbiamo una mise en abyme ben più estesa dell’intero poema (libri IX-XII), allorché Ulisse racconta le sue stupefacenti avventure di viaggio ad Alcinoo, re dei Feaci. E i raffinati Feaci, a loro volta, giocano il ruolo di pubblico ideale, allorquando ascoltano silenti il lungo racconto di Ulisse, e se ne mostrano completamente rapiti (Od. XI, 333-334).
Però, a ben guardare, Ulisse non canta né suona, bensì narra. Il ruolo di cantore spetta, invece, sempre nella terra dei Feaci e sempre nel magnifico libro ottavo dell’Odissea, a Demodoco, ovvero all’aedo di corte di Alcinoo. Ebbene, tale cantore celebra le imprese di Ulisse, che già in vita, capiamo essere divenuto leggendario ed epico a tutti gli effetti.
E Ulisse, a sua volta, tributa particolari onori proprio a Demodoco (Od. VIII, 477-481), sfidandolo poi a cantare anche quello che del re di Itaca l’Iliade non ci ha tramandato: l’inganno del cavallo (Od. VIII, 492-515).
Infine, Alcinoo dichiara che Ulisse sa ben raccontare come un valente cantore (Od. XI, 368).
Ma torniamo a Patroclo, per farvi riflettere con più attenzione, sempre grazie alle puntualissime analisi di FFD, sul perché il cantore si rivolga a lui “dandogli del tu”.
Ad esser precisi, l’aedo non “dà del tu” solo a lui: lo può dare financo ad Achille, però, questo accade solo una volta (Il. XX, 2).
Il cantore, invece, più facilmente “dà del tu” a Menelao, fratello di Agamennone, il quale è sì parte lesa, in quanto marito di Elena e, quindi, sta all’epicentro della causa della guerra, ma non è certo comandante in capo dei vari eserciti, come invece lo è Agamennone.
Comprendiamo, perciò, come Menelao e Patroclo rappresentino una sorta di figure supplenti di un’altra figura eroica più forte. Ebbene, tali figure sono particolarmente atte a suscitare le simpatie del pubblico e, di conseguenza, a facilitare l’identificazione con siffatti personaggi minori (FFD, p. 23).
Concentriamoci ora unicamente su Patroclo, che è definito “dolce” (XVII, 671; XIX, 300) e cerchiamo di capire ancor meglio perché lui abbia, più di ogni altro, le carte in regola per esser visto come il doppio più fragile dell’eroe… e non solo…
(E qui andrebbe aperta una lunga parentesi su di un libro che ebbe, ed ha ultimamente, un enorme successo a livello statunitense ed europeo e che è diventato un best-seller, specie per la comunità LGBT, una sorta di romanzo in cui Patroclo parla in prima persona. Un Patroclo di cui vien esplicitata ed amplificata la dote dell’empatia e della dolcezza. Si tratta de La canzone di Achille scritto dalla classicista Madaleine Miller, che vi consiglio caldamente di leggere, vincendo qualsiasi pregiudizio e snobismo – di cui ero la prima ad essere affetta – nei confronti di chi riscrive, specie negli USA, parte dell’epopea troiana).
Ma qual è il libro dell’Iliade dove a Patroclo è riservata una vera e propria pletora di tu? Si tratta del libro sedicesimo, quello in cui si canta la sua morte e, prima ancora, la sua discesa in battaglia – badate bene – rivestendo le armi dell’amico.
Patroclo diviene così, almeno per un congruo numero di versi, fino a quando l’inganno non sarà scoperto, il sosia di Achille.
Insomma, Patroclo, travestito da Achille, diventa una vera e propria controfigura di Achille.
Controfigura anche nello svolgersi dell’azione poetica. Infatti, nell’Iliade vien cantata la morte di Patroclo, ma non già quella di Achille, sicché la morte di Patroclo prefigura quella di Achille stesso, che avverrà fuori dal racconto, fuori dal poema.
A questo punto, non vi voglio annoiare snocciolandovi il lungo elenco nonché l’analisi circostanziata, di tutti i vari passi in cui il cantore omerico si rivolge a Patroclo con il tu. Vi basti sapere che nel libro sedicesimo se ne possono contare otto, per un totale di ben unidici tu.
Scelgo, perciò, un unico esempio: quei due versi che ci fan presagire l’imminente tragica morte di Patroclo, il quale, nonostante il dolce carattere, nell’ultima sua ora di vita, diviene spietato e sanguinario, per vendicare un caro compagno, barbaramente ammazzato da Ettore (XVI, 585; anche qui c’è un tu dedicato a Patroclo).
Ettore che, slealmente aiutato da Apollo, avrà poi la meglio sul povero Patroclo; Ettore che, di conseguenza, non potrà che venir ucciso, a sua volta, da Achille, grazie ad un soccorso, parimenti sleale, di Atena.
Ma basta così! Leggete, invece, questi due versi:
E qui chi per primo, chi per ultimo massacrasti \ Patroclo, mentre gli dèi te pure chiamavano a morte? (Il. XVI, 692-3).
Concentriamoci sulla ratio di tale domanda. Ovvero perché mai il cantore s’interroga sulla sequenza dei combattenti troiani uccisi da Patroclo? Lo fa perché, non potrà raccontare – o perlomeno non potrà farlo nei dettagli – tutta quanta la carneficina messa in opera dall’amico di Achille.
Il cantore, infatti, è sempre ben conscio che, sebbene sia sostenuto dalle Muse, le sue capacità restano limitate e dovrà comunque operare una selezione. Quella stessa selezione che l’aedo si trova a compiere su ben più vasta scala, allorché, nel libro secondo, deve render conto del lungo catalogo delle navi e soprattutto dei numerosissimi guerrieri Achei giunti per espugnare Troia (FFD, pp. 18-20). E giusto apprestandosi al tour de force di tale elenco (Il. II, 494-759), il cantore, conscio della sua impotenza, fa qualcosa che non fa quasi mai: ricorre alla prima persona singolare:
Dite adesso a me, o Muse (…) quali erano i capi e coloro che guidavano i Danai \ la folla io non dirò, non chiamerò per nome \ nemmeno s’io dieci lingue e dieci lingue avessi (…) ma dirò i capi di navi e tutte le navi (Il. II, 484-493).
Sicché il tu, che accompagna insistentemente Patroclo, ci fa intuire che il cantore non sente l’amico di Achille poi tanto dissimile da sé. Patroclo, l’ascoltatore per eccellenza, l’antenato del lettore, viene così a fondersi con il poeta, ossia con l’antenato dell’autore.
Certo in tre millenni ne è passata di acqua sotto i ponti, ma le tattiche di fondo restano assai simili, intendo dire la strategia che chi canta, chi racconta o chi scrive, mette in opera per gettare un ponte in direzione di chi lo ascolterà o lo leggerà. E tali tattiche possono giocarsi, fin dalla Grecia arcaica, nel caso che qui c’interessa, attraverso quel famigerato tu.
Inoltre, non si tratta solo d’una semplice selezione, basata sul valore di chi è degno o meno d’esser cantato (“la folla io non dirò”), ma anche su qualcosa che, in termini molto più contemporanei, potremmo definire un montaggio; innanzi tutto, la decisione di quando far cominciare una storia e quando interromperla.
L’Iliade, lo sapete, non ci narra l’intera guerra di Troia ma solo parte del nono anno e non si conclude con la città espugnata, bensì con la morte di Ettore, il più forte degli eroi troiani, il che costituisce il preludio alla caduta di Troia.
E ancora, come già dicemmo, l’Iliade non contempla la morte di Achille, ma quella della sua controfigura. E così pure il poeta, che non può mutare l’esito funesto della guerra – peraltro già noto al suo pubblico – sceglie, piuttosto, di arrestare il racconto quando più gli garba. Ecco allora che l’ultima visione che il cantore ci dà di Achille, dopo il nobilissimo incontro con Priamo, non è quella di un eroe sanguinario che si scatena sul campo di battaglia, ma quella di un Achille che dorme a fianco di Briseide: la dolce compagna ritrovata (Il. XXIV, 675-676; FFD, pp. 74-75).
Torniamo, allora, per qualche istante, accanto a Patroclo, seduto “in faccia all’amico”: Patroclo che ascolta Achille mentre canta accompagnandosi con la cetra.
Ebbene, Patroclo non solamente sta in silenzio, rapito, ma anche “attende” che Achille finisca il suo canto (Il. IX, 191). Il che, ovviamente, non significa che Patroclo si sta stancando della perfomance dell’amico, ma che, invece, pone somma attenzione a che taglio Achille vuol dare alla sua canzone.
Un Patroclo, ancora una volta, vaso comunicante tra l’autore e il suo pubblico.
Facciamo ora una breve incursione nell’Odissea, perché anche là troviamo un tu veramente clamoroso.
Forse vi aspetterete che il cantore “dia del tu” ad Ulisse o, forse, dopo quello che avete letto sin qui, non ve lo aspettate più.
Spero, infatti, che abbiate ben riflettuto sul fatto che il poeta “dà del tu” non tanto all’eroe a tutto tondo, bensì al suo doppio più fragile.
E chi è mai il doppio più vulnerabile di Ulisse?
Esiste e si chiama Eumeo e a lui il cantore rivolge addirittura una quindicina di tu.
Qualcuno di voi ricorderà che Eumeo è il porcaro, che Ulisse, da poco finalmente tornato nell’isola natia, incontra nei monti di Itaca, quando, sotto mentite spoglie, si finge un naufrago cretese (Od. XIV, 199-359). Infatti Ulisse, in un primo momento, preferisce sondare il terreno prima di avventurarsi verso la reggia, invasa dai Pretendenti di Penelope: i Proci.
Eumeo, di solito, vien visto soprattutto come il servo fedele per antonomasia: quello che ha atteso il padrone per vent’anni – una sorta di Argo (Od. XVII, 300-327) a due zampe – o anche come quello che mal sopporta i soprusi dei Proci e che, perciò, aiuterà Ulisse a sterminare tali tracotanti invasori.
Eh no, miei cari, Eumeo è molto, molto di più!
Eumeo non è solo l’ascoltatore pazientissimo delle storie (menzognere) di Ulisse in incognito: è, a sua volta, come il suo padrone redivivo, uno stupendo narratore.
V’invito caldamente, perciò, a leggere, o rileggere, il racconto di Eumeo, perché all’avvincente vicenda che lui narra (Od. XV, 402-484) conviene tributare il massimo della nostra attenzione.
Eumeo, tanto per cominciare, non è un popolano qualsiasi, bensì uomo di lignaggio regale. Suo padre, infatti, è il re dell’isola di Siria – isola non ben identificata, posta ad Oriente.
Ma come mai Eumeo è divenuto schiavo?
Vien rapito ancora piccino da una bella serva fenicia, che ha intrecciato una tresca con un trafficante, fenicio lui pure, approdato all’isola con altri suoi compagni, senza scrupoli par suo. Ebbene, questi Fenici bricconi promettono alla donna di riportarla nella nativa Sidone. In cambio lei ruberà vari gioielli della reggia e, di sua iniziativa, la perfida, propone di rapire il principino, da cui c’è da ricavare un buon guadagno, vendendolo come schiavo. E l’ignaro bimbetto è facile da portare sulla nave dei Fenici perché è solito trotterellare ovunque dietro a quella serva.
Pochi giorni dopo l’infida donna muore di morte improvvisa, fulminata da Artemide e, in seguito, Eumeo vien venduto schiavo, una volta che la nave fenicia ebbe fatto scalo ad Itaca.
Eumeo, dunque, non è soltanto l’ascoltatore, o il narratore, a tutta prova, Eumeo è un futuro re, acerbamente privato delle sue prerogative regali.
Insomma, in Eumeo bambino, e nella sua successiva vicenda di schiavo, aleggia, come in uno specchio rovesciato, lo spettro di quello che Ulisse teme al sommo grado per sé, quando, ormai non più nel fior degli anni, fa ritorno ad Itaca: la perdita rovinosa della regalità!
E non è un caso che Ulisse, alla fine del doloroso racconto del mancato re, divenuto porcaro, si dichiari profondamente turbato (Od. XV, 486-487).
Dobbiamo ora provare a concludere e lo farò accennando a quando il tu non chiama più in causa il doppio più fragile dell’eroe, ossia quello con cui il pubblico può più facilmente identificarsi, bensì direttamente l’ascoltatore: l’antenato del lettore, appunto.
E tale appello suona quanto mai esplicito ed inequivocabile, sicché si rimane stupiti, e dispiaciuti, accorgendosi come scompaia in molte traduzioni.
Alludo, in particolare al libro quinto dell’Iliade, dove si scatena l’irrefrenabile forza guerriera di Diomede, figlio di Tideo. Ebbene, il poeta non si rivolge a tale eroe, ma a chi ascolterà, e in prospettiva a chi leggerà, questi versi, che cercano di rendere la sorprendente velocità del Tidide:
E tu non avresti potuto sapere con chi parteggiasse il Tidide \ se stesse coi Troiani o con gli Achei (Il. V. 85-86; trad. it. mia).
Il cantore, insomma, si sente incapace a rendere l’ubiquità dell’eroe che, in un certo senso, ha qualcosa d’indescrivibile e, così, tramite quel tu sceglie di far partecipare il suo pubblico al suo stupore e persino al suo senso d’impotenza (FFD, pp. 27-28).
Ma non è finita qua perché mi trovo a dover fare una precisazione che quelli che non conoscono la grammatica del greco antico troveranno oltremodo pedante.
Portate pazienza!
Il fatto è che in greco non esistono solo l’indicativo e il congiuntivo, che, transitando per il latino, arrivano fino alle lingue moderne. Esiste anche un altro famigerato modo verbale, ossia l’ottativo, che può esprimere, non solo un desiderio o un auspicio, ma anche una possibilità.
Ora, che la seconda persona singolare sia qui espressa all’ottativo significa, secondo FFD (p. 67), che viene aperto al pubblico un “accesso immaginario al campo di battaglia”.
Commento acuto e brillante che mi mette, però, una piccola pulce nell’orecchio, pulce che mi sprona a spingere il gioco ben più oltre.
Siamo sicuri che attraverso lo spiraglio dell’ottativo, attraverso il pertugio di tale chance, non si faccia intravedere qualcosa di ancora più sottile?
Mi spiego: forse il cantore, che ha dovuto rivelare, suo malgrado, l’inadeguatezza dei suoi versi, sta lanciando una sfida al suo pubblico. Quel sentore di sfida che, tre millenni dopo, Baudelaire e Bufalino, assai più beffardi dell’aedo omerico, rilanciano con complice scherno.
Forse, e ripeto “forse”, il cantore sta dicendo: io non son stato capace ad esprimere bene quello che succedeva nel campo di battaglia ma tu, che grazie a me vi sei penetrato, sei proprio sicuro che avresti potuto – ecco una traccia dell’ottativo – fare di meglio?
Assai probabilmente il mio è un delirio bello e buono, ma lascio a te, “fratello” lettore, giudicare e ripensarci.
Hai tutto il tempo che vuoi! Sempre che tu lo desideri.
Note e annotazioni
Per una prima documentazione circa l’uso del tu, del voi e del lei, rimando alle interessanti annotazioni di Umberto Eco in proposito; basterà che digitiate su Google le parole chiave: Umberto Eco tu.
Avevo cominciato ad affrontare questo problema estetico in un vecchio articolo, oggi non facilmente reperibile, quando mi dedicai a ritradurre L’encomio di Elena di Gorgia, e in particolare a reinterpretarne un passo molto discusso: Gorgia e il suo “lettore”. Un’ipotesi per rileggere il sedicesimo paragrafo dell’ Encomio di Elena, “Verifiche”, anno XXXIV, n. 1-2, gennaio-giugno 2005, pp. 7-28. Rimando a tale articolo per ulteriore bibliografia (specie sul tu), nonché per accenni ad un poeta da me amatissimo, Kostantin Kavafis, che qui non tratterò, ma con cui apro il mio Verso Itaca.
Certo, dovrei parlare anche della poesia italiana del ‘900, dove pure il tu è ben presente: basti pensare a La casa dei Doganieri di Eugenio Montale. Ma cedo il passo a chi è più esperto di me in tale campo.
T.S. Eliot, Poesie, a cura di Roberto Sanesi, Milano, Mondadori, 1971. pp. 122-131.
Gesualdo Bufalino, Le menzogne della notte, Bompiani, Milano, 1988 (vincitore del Premio Strega 1988).
Charles Baudelaire, I fiori del male, a cura di Gesualdo Bufalino, Milano, Mondadori, 1983.
Rimando a Un anno con Eraclito, soprattutto ai §§ 9 e 10, dove cerco di spiegare quando e perché Eraclito ricorra alla prima e alla seconda persona singolare.
Saffo, fr. 16 Voigt; la trad. it. è di Giulio Guidorizzi (Lirici Greci. Saffo, Alceo, Anacreonte, Ibico, a cura di Giulio Guidorizzi, Mondadori, Milano, 1993, pp. 8-11), da me lievemente modificata.
Mimnermo, fr. 1 Diehl; la trad. it. è mia.
Per la questione della lettura silenziosa rimando ad un mio vecchissimo libro: L’occhio del silenzio. Encomio della lettura, Padova, Esedra, 1997 (prima edizione: Venezia, Arsenale, 1986).
Vico parla di “corpolentissima fantasia” nelle primissime pagine dedicate alla Metafisica poetica (nel secondo libro de La scienza nuova, ed. 1744) e riprende il problema della nascita dei due poemi lungo tutto libro terzo: Della discoverta del vero Omero. Come forse sapete, per Vico, Omero altri non è che tutto il popolo greco antico che per secoli compose (oralmente) l’Iliade e l’Odissea.
Françoise Frontisi-Ducroux, La cithare d’Achille, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1986 (l’ed. è italiana ma il testo è in francese).
Se desiderate far conoscenza più da vicino con i raffinati Feaci, vi invito a leggere: Perché parlar male dei Cretesi?
Se volete toccare con mano quanto Ulisse tenesse spasmodicamente alla propria fama di eroe, vi rimando a: Le Sirene e i Lotofagi son forse parenti?
Per le citazioni di Il. XVI, 692-3 e Il. II, 484-493 ho usato l’annosa traduzione di Rosa Calzecchi Onesti : Omero Iliade, Testo a fronte. Prefazione di Fausto Codino, versione di Rosa Calzecchi Onesti, Torino, Einaudi, 1990 (prima edizione “I Millenni”, 1950).
Madeleine Miller, La canzone di Achille, trad. it. di Matteo Curtoni e Maura Parolini, Milano, Feltrinelli, 2020 (ed. or. 2012).
Ecco l’elenco di tutti gli otto passi del libro XVI dell’Iliade in cui l’aedo si rivolge con un tu a Patroclo: 20; 585; 692-3; 744; 754; 787-788; 812-813; 843. Si tratta di versi molto significativi, se ne avrete voglia, leggeteli tutti.
Per onestà, non posso tacervi che ben due tu sono riservati anche ad una divinità: ad Apollo, dio della divinazione e dio che da lontano lancia mortali saette, col suo arco d’argento. Apollo, però, si vede già che è destinato a diventare anche il dio della “poesia”, visto che suona la sua bellissima cetra, con cui accompagna i canti alterni ed armoniosi delle Muse, allietando gli altri déi a banchetto (Il. I, 601-604). Il cantore omerico mima, perciò, in scala minore, tale performance apollinea, anche se, a onor del vero, le due occorrenze del tu non s’abbinano ad un Apollo che suona la cetra, bensì ad un Apollo che interviene nel campo di battaglia (Il. XV, 365; XX, 152). Tuttavia, qualcosa di “artistico” o, meglio, di “poetico” c’è: cfr. Ulteriore Appendice.
Ecco tutti i quindici passi in cui il cantore dell’Odissea si rivolge con il tu ad Eumeo: XIV, 55, 165, 360, 442, 507; XV, 325; XVI 60, 135, 464; XVII, 272, 311, 380, 512, 579; XXII, 194. Il mio discorsetto su Eumeo come doppio più fragile di Ulisse, in quanto re mancato, è tutta farina del mio sacco!
Anche Ulisse, quando deve raccontare le sue molte avventure ai Feaci, si pone il problema di dove cominciare e di dove finire (Od. IX, 14) e, pure, di cosa tagliare. Infatti, agli otto anni passati, senza nessuna gloria, nell’isola della ninfa Calipso Ulisse dedica solo tre versi (XII, 448-450), allorché li narra; in precedenza Ulisse aveva fatto una veloce allusione al suo lunghissimo e infelice soggiorno presso Calipso in un’altra manciata di versi (VII, 245-260).
Il tu che fa appello inequivocabilmente al pubblico è presente anche in altri passi dell’Iliade: IV, 429; XV, 697; XVII, 366; anche, in quest’ultimo verso, si sfiora l’indescrivibile. Un caso a parte è fornito da III, 220, passo in cui Antenore descrive il sembiante ingannevole di Ulisse, che ha l’apparenza d’un uomo adirato o senza senno, apparenza ingannevole che si rovescia nel suo opposto, non appena il re di Itaca mostra di saper parlare con grande efficacia (FFD, p. 28 e 39).
L’anonimo autore del trattato Sul sublime (cap. XXVI) loda l’espediente del cambio di persona e il ricorso al tu. Ora, non vien preso in considerazione nessun appello ad un singolo personaggio ma esclusivamente quello all’uditore, cosa che ha il pregio di stimolare quest’ultimo, “trasformando quello che lui ascolta in una visione”. E, in particolare, commentando proprio Il. V, 85, si afferma che il tu ha l’effetto di trascinare l’ascoltatore all’interno dell’azione. L’Anonimo, però, si ferma qui: non parla né d’impotenza a descrivere, né di empatia tra l’autore e il suo pubblico, né, meno che meno, di una sfida tra i due.
Consiglio caldamente a chi volesse cogliere tutte le sottili sfumature dell’ottativo in greco antico: Un modo chiamato desiderio. L’ottativo, in Andrea Marcolongo, La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco, Bari, Laterza, 2016, pp. 84-101. Senza queste pagine, scritte con esemplare chiarezza – pagine che anche chi non ha fatto studi classici può tranquillamente leggere – non avrei mai capito la differenza che c’è in greco tra eventualità (congiuntivo) e possibilità (ottativo).
Appendice
Recentemente, ho potuto veder confermato quanto qui sostengo su quello che, per capirci, ho chiamato “montaggio”; mi è successo analizzando uno studio, che non parla affatto di “montaggio”, ma che mi è stato utile per le moltissime citazioni omeriche, che peraltro mi sono preoccupata di vagliare una ad una e talora di scartare, perché non sempre precise o pertinenti: Michel Fattal, Ricerche sul logos. Da Omero a Plotino, a cura di Roberto Radice, Milano, Vita e Pensiero, 2005 (ed. or. 2001), soprattutto pp. 23-57 e relative note. Qui si mostra come il verbo légo nei poemi omerici stia a significare l’azione di “scegliere”, ad esempio, quando dei combattenti vengono arruolati per compiere una particolare azione bellica (Il. XIII, 276). Ovviamente, non si sceglie a casaccio, ma si selezionano “i migliori” (ibidem). Di modo che tale operazione presuppone un piano che governi questa raccolta (Fattal, p. 24). Si ha, così, un computo abbinato ad un vagliare. Non a caso, logismós, che da légo deriva, starà a significare, in un greco posteriore a quello omerico, “calcolo”.
Rimane da scoprire quale sia il nesso tra il significato di “raccogliere”, nel senso di “scegliere” (donde il latino eligere), e quello di “dire” sempre di légo: significato, quest’ultimo, parimenti testimoniato in “Omero”. Ebbene, si possono “enumerare” le proprie sventure o le proprie mirabolanti avventure (Od. XI, 374) e contemporaneamente farne l’oggetto di una narrazione (Fattal, pp. 25-26). Tale è precisamente il nesso tra i due significati di légo. Vediamo, ad esempio, Ulisse e Penelope che, nella prima notte che trascorrono assieme nel talamo nuziale, dopo vent’anni, non solo godono nel far l’amore ma anche godono nel parlarsi. Ulisse, in particolare, racconta. E qui sembrerebbe che Ulisse narrasse (légo) “tutte le sue avventure” (Od. XXIII, 308), invece, c’è già una selezione – che Fattal non sottolinea affatto – non solo perché il racconto dura molto meno di una notte, ma perché nei versi successivi (vv. 310-341), il cantore ce la esemplifica, facendocene un riassuntino.
Un altro esempio, parallelo a questo, lo abbiamo nelle parole con cui Ulisse, sotto mentite spoglie, mostra di apprezzare il racconto di Eumeo, dicendogli che lui gli ha “narrato (légo) uno per uno” i dolori che ha sofferto (Od. XV, 487). Però, a ben guardare, questi dettagli son già il frutto di una sapiente cernita-montaggio, che ha reso il racconto del re-porcaro ancora più efficace proprio nella sua incisiva brevità.
Allora ho ripensato a quando Ulisse, in un verso che già conosciamo (Od. IX. 14), si appresta a dispiegare il suo lungo racconto ai Feaci, ebbene, in quel caso si preoccupa, al pari del cantore, di quale cosa dovrà “narrare (katalégo) per prima e quale per ultima” (Od. IX, 14), laddove questo verbo presuppone un racconto ordinato ed articolato. E ho ripensato pure a come Alcinoo lodi l’arte di raccontare (katalégo), sempre di Ulisse, proprio perché è in grado di dare una “bella forma” (morphé) alle sue storie. Abbiamo, anche in questo caso (Od. XI, 367-368), un sapiente montaggio che il re dei Feaci mostra di apprezzare non tanto perché si tratta di storie veritiere quanto di racconti ben costruiti, che l’ascoltatore può “vedere” (Od. XI, 363-366), con gli occhi dell’immaginazione. E , perciò, l’accento vien posto sull’efficacia.
Concludendo, le ricerche di Fattal hanno qualche pregio (soprattutto laddove vien evidenziato il legame tra légo inteso come “scegliere” e come “raccontare”), tuttavia non gli posso perdonare, oltre al suo pressappochismo, di non aver speso nemmeno una parola, anche nel resto del suo libro, sul malioso lógos di Gorgia. E questo mi risulta ancor più incomprensibile proprio perché Fattal fa emergere come, nei poemi omerici, légo, quando significa “dire”, non si leghi alla ricerca della verità, quanto piuttosto alla seduzione (Fattal, p. 14 e p. 26): cfr. ad es. Od. I, 56 (i dolci e fascinosi lógoi con cui Calipso tenta di far dimenticare Itaca ad Ulisse); Il. XV, 393 (Patroclo consola con dolcezza un amico ferito con il balsamo dei suoi lógoi, mentre lo sta medicando).
Del resto, perché meravigliarsi? L’ostracismo dei poveri Sofisti continua a non avere fine…
Ulteriore Appendice
Quando investigai sulle varie occorrenze di Apollo nell’Iliade, ebbi una gran bella sorpresa: trovai un’immagine che il giovane Nietzsche erroneamente attribuisce ad Eraclito. In Un anno con Eraclito (soprattutto nei §§ 4 e 16), avevo esaminato a fondo il fr. 52: quello dove si diceva che tutto il corso del tempo (aión) è un bambino (paîs) che gioca con i pezzi di una scacchiera. Ebbene, Nietzsche (La filosofia nell’epoca tragica dei Greci, § 7, ed. Colli-Montinari) interpreta in maniera alquanto fantasiosa e faziosa questo frammento e parla di un paîs che costruisce castelli di sabbia in riva al mare per poi distruggerli. Ora, capite bene che spostare i pezzi su di un tavoliere è un’azione ben più ponderata e calcolata dell’atto di edificare e poi distruggere “per capriccio”. Nietzsche applica tale metafora alla sua idea del fare arte – o almeno quella che ne ha in età giovanile – sicché ne vien fuori una concezione dell’arte sommamente irrazionale e irriflessa. Esattamente il contrario di quanto abbiamo cercato sin qui di mostrare a proposito dei poemi omerici, dove il canto, che per i Greci arcaici è la forma artistica per eccellenza, s’accompagna da subito con la riflessione sul canto e sulle strategie nel costruirlo.
Tuttavia, l’immagine del bimbo che si trastulla in riva al mare, pur così fuorviante per farci comprendere il pensiero di Eraclito, era così bella e così ben strutturata che mi sembrava impossibile che Nietzsche se la fosse inventata di sana pianta. Da qualche parte nel mondo greco doveva averla pur pescata!
Infatti, eccola poco prima di uno dei due passi in cui l’aedo “dà del tu” ad Apollo. Siamo nel libro quindicesimo e gli Achei, per tentare di frenare la minacciosa avanzata dei Troiani nel loro accampamento, avevano edificato un muro di difesa vicino alle navi. E qui interviene Apollo (che parteggia per i Troiani): “(…) e Apollo \ con l’egida venerata abbatté il muro degli Achei \ senza fatica, come un bimbo che sulla riva del mare costruisce i suoi giochi infantili di sabbia e poi di nuovo li distrugge con le mani e con i piedi giocando” (Il. XV, 360-364; trad. it. Calzecchi-Onesti, da me leggermente modificata). Non si dice esplicitamente “castelli di sabbia” ma, siccome nei versi vicini si parla di una fortificazione, è evidente che l’immagine in trasparenza è proprio quella.
Altro particolare interessante: l’attività del paîs è contrassegnata dal verbo poiéo: che in seguito indicherà anche il “fare poesia”. E proprio nel verso immediatamente successivo (Il. XV, 365), il cantore dà del tu ad Apollo.
Certo mi si può obiettare che nell’Iliade Apollo si limita a suonare la cetra (Il. XXIV, 68) mentre il canto spetta alle sole Muse (Il. 603-604), tuttavia già nell’Odissea il cantore è istruito indifferentemente dalle Muse o da Apollo (Od. VIII, 488: così parla Ulisse di Demodoco).
Non dimentichiamo, inoltre, che Apollo, mentre gli altri dèi si azzuffano bellamente tra di loro, si rifiuta di combattere con suo zio Poseidone (che parteggia per gli Achei) e depreca che due divinità lottino per dei mortali, che non valgon nulla “simili a foglie che ora \ crescono in pieno splendore, mangiando il frutto del campo, \ e di lì a poco si consumano esamini” (Il. XXI, 464-466, trad. it. Calzecchi-Onesti, lievemente modificata).
Quest’immagine, che equipara gli uomini alle foglie, riecheggia certi splendidi versi del canto sesto dell’Iliade, quando Glauco esibisce a Diomede la propria genealogia. Colà, però, c’è uno spiraglio di rinascita perché, se le stirpi degli uomini nascono e poi vengon meno, le foglie son evocate nella sequenza inversa: autunno, in cui il vento le getta a terra, e primavera, in cui le piante rifioriscono (Il. VI, 146-149).
Mentre Apollo mostra di non tener in gran considerazione gli uomini equiparandoli solo a foglie morenti. Ne possiamo arguire che, se Apollo è destinato a diventate il dio della “poesia”, di cui l’aedo è il rappresentante tra gli umani, è significativo che distrugga quelle opere degli uomini che non rimarranno.
Non a caso, giusto nel libro sesto dell’Iliade si celebra anche la funzione immortalante del canto che permette agli uomini di durare, anche dopo la loro morte perché verranno cantati “dagli uomini del futuro” (Il. VI, 358)… sempre se saran degni d’essere cantati.
Concludendo, ci credereste? Non ho mai incontrato nessuno tra i molti esegeti di Nietzsche, quelli che conosco personalmente, o quelli che mi è capitato di leggere o rileggere, che si sia accorto di questa fascinosa traccia omerica.
E neppure ho mai visto citati questi versi (Il. XV, 360-364) in quanti amarono rivisitare la figura del dio Apollo, al di là delle ingombranti semplificazioni che gli son state affibbiate in Nascita della tragedia. Nada de nada né in Walter Otto, e nemmeno in Giorgio Colli!