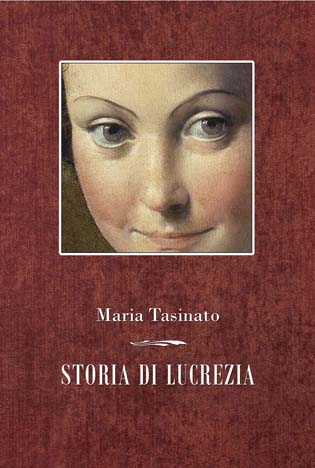Storia di Lucrezia uscì nel 1993 – ossia già dopo un bel pezzo che il romanzo era finito – solo in un centinaio di copie, presso un oscuro editore di Abano Terme. Lo pubblicai con uno pseudonimo, adottando il nome che più mi sarebbe piaciuto avere (Livia) e il cognome tosco-emiliano della mia nonna paterna (Forlai), dato che il mio vero cognome, maledettamente venetico, mi è sempre stato sullo stomaco. Usai l’espediente letterario più vecchio del mondo: finsi d’essere in possesso di un manoscritto che mi sarebbe stato consegnato dall’autrice (Livia Forlai, per l’appunto) e raccontai il tutto in un’ampia cornice – che forse un giorno metterò in questo sito – ed ero ultraconvinta che tutti l’avrebbero presa per quello che era: pura finzione narrativa. Povera illusa! In molti credettero che Livia Forlai esistesse davvero e… a me cascarono le braccia. Per cui oggi mi son decisa a mettere il mio nome anagrafico sulla copertina, ma sarei tranquillamente disposta a rinunciarvi un’altra volta, se questo potesse garantire a Storia di Lucrezia d’essere letta dal maggior numero di persone possibile. Perché rispetto ad una storia, l’identità dell’autore, con tutti i suoi deliri egoici, è cosa decisamente secondaria: importa, invece, che la storia sia scritta bene e che sia appassionante per chi la legge.
Un mio vecchio professore di liceo, il compianto Enzo Mandruzzato, prodigo di sentenze fulminanti, ebbe a dire che si nasce “barocchi” e si muore “classici”. Quando sentii questo detto, avevo circa 16 anni e ne rimasi molto colpita sebbene perplessa: pensavo che essere “barocchi” fosse un’esigenza irrinunciabile e intramontabile. Per dirla tutta, avevo un debole per la scrittura rigogliosa di aggettivi rari e ben piazzati, sicché ero lungi mille miglia, come ancora lo restai ben oltre i 40 anni, da quell’austero e volutamente disadorno minimalismo cui approdai solo recentemente. In conclusione, feci esattamente il percorso predetto da Mandruzzato, nutrendo sempre più il sospetto che questo sia un iter – un iter verso la sottrazione – che tutti quelli che non muoiono giovani son destinati a percorrere. Sia chiaro, perciò, che non rinnego affatto la mia scelta iniziale di un italiano raro, prezioso e iperletterario: era un cammino che andava fatto. Ma sia chiaro, altresì, che la mia scrittura non fu un progressivo ritorno alla naturalezza, poiché la stessa semplicità, essendo frutto di una pratica o, meglio, di un duro esercizio, è comunque artificiale. Perché, ci tengo a sottolinearlo, senza artificio non vi sarebbe scrittura, neppure la più la disadorna.
Nei lunghi anni di gestazione di Storia di Lucrezia (dai miei 28 ai 36 anni), il mio lavoro si svolse su due fronti. Da un lato, collezionavo e catalogavo aggettivi o brevi frasi che, con una sola riuscita pennellata, suggerivano immagini pregnanti e sorprendenti, dall’altro, lavoravo sodo alla trama della vicenda. Questa mia raccolta di squisiturie – lo dico senza nessunissimo intento peggiorativo – pescava a piene mani anche in certi autori, ingiustamente qualificati come “minori”, dell’inizio 900 e degli anni 20, quali Annie Vivanti e Guido da Verona, ma soprattutto nell’incomparabile ed eccentrica prosa di Tommaso Landolfi, autore geniale, morto meno di 35 anni fa, ma che oggi rischia di venir dimenticato. A Landolfi, tra l’altro, dobbiamo magistrali traduzioni di Gogol (I racconti di Pietroburgo) e di Dostoevskij (Ricordi dal sottosuolo). Insomma, se non lo conoscete, v’invito caldamente a leggerlo. In contemporanea, sul fronte del plot, meditavo non solo come costruire la trama, ma pure delineavo via via i caratteri dei personaggi, decidendo in seguito quali mantenere nella vicenda principale e quali collocare, invece, nei flashback.
Quanto al tipo di storia, non riuscivo a togliermi dalla testa un’affermazione di Gustave Flaubert, quando aveva solo 25 anni, un Flaubert che dichiarava a bruciapelo di avere la vocazione del saltimbanco e che aggiungeva di ammirare la bigiotteria luccicante allo stesso modo dell’oro. Applicando tutto questo al romanzo che avrei scritto, non ebbi alcuna remora ad optare per un drammone volutamente kitsch; in particolare, un torbido drammone familiare, scelta che favoriva gran colpi di scena oltre che tinte piuttosto fosche. Chi abbraccia il Kitsch sovente non si prende troppo sul serio e tale autoironia spessissimo viene, invece, dimenticata da chi ha la pretesa di scrivere qualcosa di più “elevato” o più “impegnato” o più… vattelapesca.
Questo breve romanzo ha anche un certo valore documentario: essendo stato concepito e scritto tra il 1978 e il 1986, testimonia della felice temperie degli anni settanta, ossia di quel modo di pensare libertario e “libertino” che, al giorno d’oggi, diviene sempre meno immaginabile. Da anni stiamo immersi – anche chi ne è alieno finisce per restarne contaminato – in una melassa di esaltazione della famiglia, della coppia e compagnia bella, ovvero nel trionfo di un moralismo spesso ipocrita e talora rampante.
A costo di sembrarvi monotona, insisto nel sottolineare che Storia di Lucrezia non ha nessun retrogusto autobiografico: io sono – oramai è più corretto dire: sono stata – infinitamente meno bella, meno affascinante, meno audace della protagonista del romanzo. Non sono mai vissuta in un castello, non ho mai avuto rapporti familiari simili a quelli che emergono dalla vicenda… anzi! Insomma tutto è finzione.
Nella mia scelta del Kitsch, ho voluto poi rimettere in scena un topos letterario collaudatissimo, specie alla fine del 700 e ancora nell’800: quello della fanciulla perseguitata. Come reagisca però Lucrezia a tale persecuzione, beh non ve lo posso anticipare. Però ne approfitto per dirvi che non ho mai condiviso certo vittimismo tipico di tanto femminismo: una donna che si rispetti sa sempre come difendersi. Basta così!
Per concludere, prima di decidermi a mettere sul mio sito, questo piccolo romanzo, ho voluto fare un esperimento: lo diedi da leggere ad una ragazza di 26 anni (Lorenza Bottacin Cantoni, che poi ha corretto le bozze della battitura definitiva e che ringrazio di cuore) per vedere come reagiva. Perché questa fanciulla è sì un’amante della grande letteratura, ma è pure appassionata ad autori maledettamente contemporanei per non dire post-moderni, tipo Don De Lillo. Insomma tale lettrice era ideale per fungere da cartina di tornasole: per farmi capire se certi preziosismi e certi arcaismi sarebbero suonati incomprensibili o, peggio, ridicoli alle nuove generazioni. Con mia grande sorpresa, Lorenza si mostrò parecchio entusiasta del romanzo e, solo allora, mi decisi a “toglierlo dal cassetto”.
Vi siete incuriositi? Allora scaricate l’intero romanzo